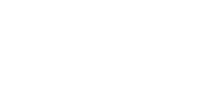di Emanuele Giordana da Sihanoukville
Sihanoukville – L’edifico campeggia in pieno centro città. E’ circondato da un alto muro con filo spinato e una porta d’ingresso con guardiani e telecamere. A prima vista sembra un palazzo come un altro anche se le misure di sicurezza all’esterno sono singolari. Ma a guardar bene, si nota che tutte le finestre sono sbarrate. La cosa sarebbe abbastanza comune se le sbarre servissero a
Perché la mafia cinese abbia scelto Sihanoukville richiede un passo indietro. Recentemente, le autorità cambogiane hanno esaminato la bozza sulla seconda fase del piano per la creazione di una zona economica speciale multifunzionale nella città (Zes). E’ un progetto del 2006 e che ha attraversato fasi diverse e mira a trasformare la città in un’importante zona economica del Sudest asiatico, con un’area industriale avanzata per le catene di produzione regionali e globali attraverso
Adesso però Sihanoukville è tornata a rivivere e le attività sono riprese. Molti degli scheletri che la facevano assomigliare a una città bombardata nel 2020 sono stati ultimati o sono in fase di riavvio lavori. Non è una percentuale elevatissima ma un buon terzo degli edifici abbandonati sembra tornato a nuova vita. I prezzi dei terreni e degli immobili, impazziti durante l’epoca dei Casinò, sono scesi e consentono nuovi investimenti. Puliti e non. Un occhio vigile infatti non fa fatica ad accorgersi
Questi edifici sono circondati da muretti alti o da paratie di ondulato che nascondono la vista dei piani bassi. Per raggiungerle bisogna infilare stradine che per lo più sono cieche. Davanti all’ingresso degli edifici, una porta guardata a vista – a volte preceduta da una sbarra di ferro che fa da check point – chiude l’ingresso agli indesiderati. Non sono semplici “portieri”. Hanno quasi tutti una divisa nera e facce poco amichevoli. Potrebbero essere armati. Sugli angoli sbucano telecamere. E’ la seconda vita che la mafia cinese ha scelto per Sihanoukville. Ben oltre i Casinò e ben oltre il miraggio di Shenzen: da regina dell’azzardo a “Scam City”, dove un esercito di schiavi al computer o al telefono imbroglia con perizia migliaia di persone ogni giorno.
Sono strutture che, secondo tre ricercatori che da anni studiano le Scam City – Ivan Franceschini, Ling Li e Mark Bo – “rappresentano una nuova manifestazione del capitalismo predatorio”: il compound capitalism. Questi edifici sono in effetti dei veri e propri centri (compound) dove un esercito di schiavi lavora in rete su più cellulari una media di 12-14 ore al giorno architettando truffe telefoniche che mirano a saccheggiare i conti correnti delle malcapitate vittime che rispondono a un primo messaggio che arriva su Wathsapp, Instagram o altre piattaforme. Di solito da un’avvenente giovane asiatica/o.
Uno di questi compound, strafotografato, si trova in pieno centro: a Mittapheap, distretto 1801, un chilometro dal nuovo porto della città, a ridosso della Sihanoukville Port Special Economic Zone (Spsez). La polizia l’ha chiuso dopo una delle rare operazioni di pulizia in seguito soprattutto a pressioni della Cina. Ma l’esercito di scammisti – spesso avvisato per tempo – viene spostato altrove prima della perquisizione. E del resto non lontano da lì, si nota un altro edifico che ha tutta l’aria di essere uno scamcompound che vive la sua ordinaria quotidianità. Indisturbato. Lo si capisce perché,
Verso Otres, la zona delle spiagge, c’è uno dei più famosi chiamato K99. Non è riparato da altri edifici e campeggia solitario lungo una strada chiusa dove c’è al massimo qualche ambulante. Recintato da mura, ha l’aria di una caserma. Tutti sanno cosa succede a K99 ma i suoi padroni non sembrano preoccuparsene. Non si nascondono.
Franceschini e i suoi colleghi hanno raccolto decine di testimonianze, ricostruito la gerarchia nei compound, il traffico di umani, le torture e persino dimostrato quanto costa ai prigionieri guadagnarsi il salario: devono pagarsi dal cibo al posto letto. Se no son botte. Secondo le Nazioni Unite questo esercito conta nel Sudest asiatico oltre 200mila schiavi, la metà dei quali in Cambogia. E secondo John M. Griffin e Kevin Mei dell’Università americana di Austin, il giro d’affari si aggira attorno a 75 miliardi di dollari in conti di deposito sospetti. Soldi che si fanno soprattutto con le truffe prodotte da questa nuova forma di schiavitù tra Cambogia e Myanmar ma anche nel Laos.
In copertina: Sihanoukville, la ripresa dei lavori. Nel testo: Norodom Sihanouk, il monarca rosso (credit: Rob Croes per Anefo – Archivio nazionale olandese). A seguire: un casino in città. Finestre sbarrate e muri col filo spinato in centro. L’edificio K99. Tutte le altre foto sono proprietà dell’autore e dell’Atlante e si possono utilizzare solo citando la fonte con link all’articolo da cui sono tratte