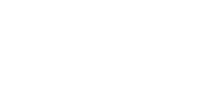di Emanuele Giordana
Da Khartum ad Algeri, dalla Thailandia al Myanmar, da molti Paesi africani fino alla lontana Indonesia. Sono ancora i militari a dettar legge, in modo più o meno evidente e con ruoli di primo o di secondo piano. Un piano che in Occidente, dove i militari sono apparentemente relegati solo a una funzione difensiva e stanno al di fuori delle politica, restano però ancora i protagonisti più o meno occulti degli investimenti nel settore della difesa: da quelli in tecnologia a quelli in sistemi d’arma. Ma l’attenzione in queste ore è tutta rivolta all’Africa dove, nel giro di poche settimane, due dittatori, espressione di una gerarchia di potere non certo estranea agli uomini in mimetica, si sono dimessi. O meglio, sono stati dimessi dai loro stessi confratelli, gli stessi che fino a qualche giorno prima erano al loro servizio. Sono stati infatti capi di stato maggiore e ministri della Difesa – Ibn Auf in Sudan, Gaid Salah in Algeria – ad annunciare il cambio di regime. Arrestato il primo e dismesso il secondo per motivi di salute (salvo l’apertura di un dossier contro la “banda Bouteflika), Sudan e Algeria sono due modelli simili ma dall’evoluzione ancora imprevedibile. In comune hanno una pressione del basso che si è fatta forza ineludibile coniugando malessere e malcontento a necessità di cambiamento. Uguali sono stati i passi delle élite: delegittimare il presidente, prendere in mano le redini della corsa e promettere un periodo di transizione verso nuove elezioni. Eppure, in queste ore, il caso sudanese sembra distaccarsi dalla routine dei colpi di stato. La giunta sudanese praticamente non ancora formata (Ibn Auf ha lasciato) sembra aprirsi al dialogo al contrario di quanto avviene in Algeria dove la vecchia guardia non ne vuole sapere di concedere più di quanto ha deciso.
Se son rose – dice un vecchio adagio – fioriranno. Ma quanto ci si può fidare delle aperture sudanesi? Quanto un regime militare, financo abbozzato, può essere sincero nelle sue promesse? Il problema dei militari – salvo rarissime eccezioni – e’ quello di sentirsi i depositari dei valori nazionali. Il che in un certo senso è anche vero. Ma questa consapevolezza, ordinata da uno spirito gerarchico di servizio, si trasforma di solito in un’autocratica visione del potere che riesce ad essere, al massimo, populista e paternalista. Il padre concede finché non gli sembri che il figliolo stia tirando troppo la corda. L’esatto contrario di ciò che vuole la regola democratica una testa un voto: ossia accettare i risultati anche quando non ci piacciono. Un argomento che con i militari non sempre funziona.
Gli esempi sono moltissimi. I più recenti? Le elezioni tailandesi concesse da una giunta militare con una legge elettorale bloccata che le consente comunque di governare. Persino l’Indonesia, che va al voto mercoledi prossimo, non è esente dalle pressioni dei militari (o ex militari). E non solo perché lo sfidante di Joko Widido (attuale capo di Stato civile) è un ex generale. Ma perché in questi anni il riformatore Widodo ha dovuto fare i conti con una casta che per 32 anni – durante l’era Suharto – ha goduto di privilegi e impunità e che ancora ha una forte influenza sulla vita politica interna. Nel Pakistan di Imran Khan – per citare un premier da poco eletto – i militari sono ancora molto influenti e il loro potere, come in parte in Indonesia, passa anche per il controllo di larghe fette dell’economia locale. E ancora, per citare un’altra esperienza elettorale in corso, quanto contano i militari nell’India esempio di democrazia ormai centenaria e non a caso famosa come la “democrazia più popolosa del pianeta”? C’entrano in doppia chiave: Narendra Modi – premier in cerca di riconferma – non è esente dalle loro sirene quando si tratta di comprare nuove armi per difendersi dai nemici pachistani. Ma è lo stesso Modi a sfruttare l’immagine di un esercito eroico appena uscito dall’ennesimo scontro bellico col Pakistan per capitalizzare voti agitando paura e insicurezza come slogan elettorali.
In altri termini, se la maturità di un Paese si può determinare anche dal rapporto tra il suo esecutivo, il parlamento – espressione della volontà popolare – e le forze armate, in ogni parte del mondo queste ultime giocano un ruolo significativo – dal Venezuela agli Stati Uniti, da Israele a Teheran. E’ un ruolo importante e che deve non solo essere controllato ma che non dovrebbe mai travalicare la sua funzione (come ad esempio accade nel Brasile di Bolsonaro). Molto spesso la tentazione di sbilanciare questo rapporto delicato riaffiora anche nelle democrazie più collaudate, sia da parte dei civili, sia da parte dei militari. Il Sudan dunque può essere un laboratorio interessante ma che va osservato con cautela. Ogni più piccola rottura di questo fragile equilibrio – che è il rapporto tra civili e militari e che non dovrebbe mai vedere al comando di un Paese questi ultimi – può essere l’inizio di una parabola involutiva anche violenta. Di un nuovo conflitto, di nuovo dolore e di nuove vittime
Nell’immagine di copertina la Battaglia di San Romano di Paolo Uccello