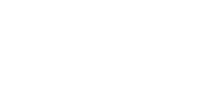di Alessandro De Pascale
Nonostante i divieti di assembramento imposti dalle autorità, in Turchia non si fermano le proteste di piazza. Da ben tre settimane centinaia di migliaia di persone scendono in strada nelle principali città contro l’arresto avvenuto il 19 marzo del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, accusato di corruzione e terrorismo, ritenuto uno dei più forti rivali politici del presidente Recep Tayyip Erdoğan. Dura la repressione della polizia, che nel tentativo di disperdere la folla impiega cannoni ad acqua, gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Oltre 2.000 le persone in stato di fermo, almeno 300 quelle incarcerate dall’inizio delle manifestazioni. La maggior parte di loro ha tra i 18 e i 23 anni, perché a sfidare le restrizioni governative e animare le proteste sono soprattutto studenti universitari. Giovani che nella loro vita hanno vissuto sempre sotto Erdoğan, come primo ministro o presidente della Turchia ininterrottamente al potere da 22 anni. Dietro le sbarre è finito anche chi cerca di raccontare le proteste: la Procura della Repubblica di Istanbul ha chiesto ieri condanne fino a tre anni per il fotografo dell’agenzia France-Presse Yasin Akgül, per il reporter di Now Haber Ali Onur Tosun, per i fotoreporter Bülent Kılıç, Gökhan Kam e Kurtuluş Ari e per i giornalisti Zeynep Kuray e Hayri Tunç.
Iniziate a Istanbul il 19 marzo, giorno dell’arresto di Imamoglu, le proteste si sono rapidamente estese, coinvolgendo 55 delle 81 province del Paese. Diversi campus universitari sono stati occupati e sono stati rapidamente eletti gruppi di coordinamento per organizzare le proteste di piazza della sera. Il tutto, nonostante lo stretto controllo esercitato delle autorità anche in ambito universitario: rettori di nomina governativa, polizia e infiltrati negli atenei, chiusura delle associazioni studentesche. “Lottano per la democrazia e per la fine dell’era Erdoğan – spiega all’Atlante chiedendo l’anonimato un’attivista turco che vive in Italia – ma ora anche per ottenere la libertà dei loro compagni arrestati”. Il nostro interlocutore è uno dei tanti che negli ultimi anni ha lasciato la Turchia: “Deriva autoritaria, crescente islamizzazione, repressione del dissenso, assenza di giustizia, violazione dei diritti umani, crisi economica e abitativa, aumento del costo della vita. Le giovani generazioni faticano sempre di più nel quotidiano e spesso non vedono un futuro nel proprio Paese”. A suo dire il malcontento sarebbe così generalizzato che è scesa in piazza sia l’estrema sinistra, sia l’estrema destra, con al centro studenti e giovani lavoratori. Proteste di questo tipo non si vedevano dal 2013, quando manifestazioni giovanili nate contro il progetto di costruire un centro commerciale a Gezi Park (l’ultimo spazio verde al centro di Istanbul), ugualmente represse duramente dalle autorità, chiesero maggiore democrazia e libertà. Persino a Berlino migliaia di persone hanno marciato in questi giorni in segno di solidarietà (in Germania vivono circa tre milioni di turchi).
Il Partito Popolare Repubblicano (CHP) al quale appartiene il sindaco di Istanbul arrestato è il più antico del Paese. È stato fondato nel lontano 1923 dal generale Mustafa Kemal Atatürk, padre della Turchia repubblicana moderna e primo presidente di questa nazione nata alla fine della Prima guerra mondiale dalla dissoluzione dell’Impero Ottomano. Erede quindi del kemalismo, continua a rappresentare la principale forza politica laica e socialdemocratica del Paese, raccogliendo voti tra professionisti, accademici, burocrati e dalla minoranza musulmana alevita. Seconda forza politica più votata, dopo il Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) di Erdoğan, il CHP ha perso di misura le ultime elezioni generali del 2023, ottenendo al secondo turno il 47,82% dei voti, contro il 52,18% dell’attuale presidente. Alle prossime presidenziali del 2028 Erdoğan non potrà più candidarsi, a meno che non cambi la Costituzione. Il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, politico carismatico e musulmano praticante in grado di attrarre anche il voto di molti religiosi, era quindi ritenuto un buon candidato alle presidenziali. La sua investitura ufficiale è arrivata il 23 marzo, quattro giorni dopo il suo arresto e la relativa sospensione dall’incarico di primo cittadino di Istanbul, con delle primarie dall’alto valore simbolico alle quali ha ottenuto 15 milioni di voti.
Parlando ieri al Palazzo presidenziale nella capitale Ankara in occasione del 180° anniversario della polizia nazionale turca, Erdoğan ha elogiato il loro lavoro nel mantenimento dell’ordine pubblico: “Le nostre forze di sicurezza non hanno permesso ai teppisti di prendere piede nelle nostre strade con il pretesto di far deragliare a Istanbul un’indagine per corruzione”. Inchiesta che per l’opposizione e i manifestanti è politicamente motivata dal tenere İmamoğlu fuori dalla corsa per la presidenza del Paese. Sempre ieri, l’assemblea del Consiglio d’Europa ha votato quasi all’unanimità (contrari solo i parlamentari turchi appartenenti al partito di Erdoğan e i nazionalisti dell’MHP suoi alleati) un risoluzione che chiede che “le autorità turche rilascino immediatamente il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, e facciano cadere le accuse infondate nei suoi confronti e quanti coinvolti nella stessa inchiesta”. Oltre all’ormai ex primo cittadino sono oltre 100 le persone finite in carcere nell’ambito di quell’indagine.
La Turchia fa parte della Nato (il suo esercito è il secondo dell’Alleanza atlantica) e mira a entrare nell’Unione europea. Questione sollevata dal portavoce della Commissione europea, Guillaume Mercier: “In quanto membro del Consiglio d’Europa e candidato dell’UE, la Turchia deve sostenere i valori democratici. I diritti dei funzionari eletti, nonché il diritto a manifestazioni pacificamente, deve essere pienamente rispettato”. A suscitare preoccupazione c’è infine un disegno di legge che obbligherebbe i fornitori di servizi over-the-top (come WhatsApp, Telegram, X e similari) ad aprire una sede locale nel Paese se superano 1 milione di utenti attivi in Turchia. Consentendo alle autorità di bloccare l’accesso a social media e piattaforme di messaggistica per motivi di “sicurezza nazionale”, anche senza l’intervento di un tribunale. Attualmente l’Autorità per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (BTK) turca ha la facoltà di ridurre la larghezza di banda fino al 90% in situazioni di emergenza, rendendo di fatto inaccessibili i servizi online colpiti, ma per un massimo di 24 ore.
Nella foto in copertina, il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ©kafeinkolik/Shutterstock.com