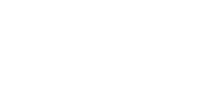di Rita Cantalino
La prima cosa da chiarire, quando si parla di impatti delle attività militari, è che ci muoviamo nell’ambito del probabile. Non esiste una rendicontazione certa, strutturata e puntuale. Nessuna istituzione nazionale, internazionale o globale l’ha mai chiesta. In Italia dati sono talmente nebulosi che, all’interno di questo approfondimento, ci muoviamo a tentoni attraverso ipotesi articolate che sommano, sottraggono, moltiplicano o dividono, a partire dalle poche informazioni a nostra disposizione. L’aura di mistero che circonda le più di 120 basi militari segrete disseminate lungo lo Stivale, si estende anche a quello che deriva dalla loro esistenza, come si estende ai traffici internazionali che portano il nostro paese a vendere a paesi impegnati in un genocidio.
Alcune cose, però, le sappiamo per certo. Sappiamo che migliaia di persone, in Sardegna, hanno pagato con la vita la subalternità del nostro paese alle disposizioni NATO. Sappiamo anche che il settore della Difesa ha un gruppo di lavoro impegnato per la transizione, ma gli unici documenti reperibili, come vedremo, non sembrano testimoniare una presa di coscienza dell’entità del danno.
In questo approfondimento proveremo, con i pochi strumenti a nostra disposizione, a costruire un quadro: qual è l’impatto climatico del settore militare e dell’apparato industriale a esso connesso? Quanto inquiniamo e quanti fondi pubblici destiniamo alla produzione di questo inquinamento? Cosa stiamo facendo, al di là dei proclami, per ridurre la nostra impronta carbonica?
Dossier/ Guerra alla Terra: l’impatto ambientale delle attività militari (1)
*In copertina Foto di Michele Bitetto su Unsplash, di seguito la base militare di Marina di Pisa

Le emissioni dichiarate
Il National Inventory Report del 2020 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti (Unfcc), per il settore militare nazionale, contiene solo il dato sulle emissioni mobili. Nel 2018, anno di riferimento del documento, le emissioni legate all’utilizzo di combustibili da trasporto erano 341 chilotoni. Il chilotone è un’unità di misura per calcolare l’intensità di esplosioni: equivale alla forza meccanica generata dall’esplosione di 1.000 tonnellate di tritolo.
Non abbiamo dati sulle emissioni fisse, quelle cioè generate dalla numerose basi militari distribuite sul nostro territorio [1, 2, 3]. Ipotizzando che i numeri siano analoghi a quelli delle emissioni mobili, cioè a un intermedio a quello di Francia e Germania, l’Osservatorio su Conflitti e Ambiente (Ceobs) ne ha elaborato una stima. Il calcolo è stato elaborato a partire dalla somma delle emissioni dirette di siti militari o attrezzature (Scope 1) e di quelle che si verificano altrove, ma dipendono dall’elettricità e dal calore utilizzati (Scope 2) del settore. A questo dato, sono state aggiunte le Scope 3 nazionali, le emissioni cioè legate alla catena di fornitura nel Paese. Secondo questa ipotesi, le basi militari in Italia sono responsabili dell’emissione di 1,8 milioni di tonnellate di gas CO2 equivalenti.
Mancano anche i dati sull’impronta carbonica legata al consumo di energia degli apparati militari. Anche qui è possibile azzardare ipotesi, tutte al ribasso. Se consideriamo il ciclo di vita medio di un esercito in Europa, l’impronta carbonica di quello italiano dovrebbe essere di più di due milioni di tonnellate di CO2e. Questi calcoli, è bene ribadirlo, si basano sul presupposto che la quantità di emissioni fisse e mobili si equivalgano: sono solo indicativi.
Le emissioni delle industrie militari
Anche per quanto riguarda le emissioni legati alle industrie militari non abbiamo informazioni complete. Sappiamo la quantità emissioni generate dalle quattro principali aziende che operano in Italia: Leonardo (183.3 chiloton di CO2e); Fincantieri (20.1); la francese Thales (3.5) e la statunitense Northrop Grumman (0.9). A partire da questi numeri, combinati con la percentuale di vendita del settore e del numero di dipendenti per impresa, si può ipotizzare che l’intera industria produca 208 chiloton di emissioni. In media 7,9 tonnellate per dipendente. Anche qui, tuttavia, stiamo considerando unicamente le Scope 1 e 2.
Dati alla mano, l’impresa con la maggiore impronta carbonica è Leonardo. La stima approssimativa dell’impronta carbonica dell’intero settore si aggira intorno ai 2,6 milioni di tonnellate di CO2e, calcolati incrociando diverse informazioni. Moltiplicando la media ponderata di emissioni per singolo dipendente (7,9 tonnellate) per il numero complessivo di dipendenti (circa 62.000), si può ipotizzare che le emissioni totali si aggirino intorno alle 492mila tonnellate, con un’impronta carbonica per dipendente pari a 42,7 tonnellate.