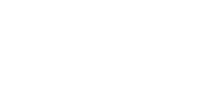di Sara Cecchetti*
Della Repubblica Democratica del Congo non si sente parlare spesso. Il conflitto, che continua a dilaniare la parte orientale del Paese (sebbene vada avanti da oltre tre decenni) sembra venire costantemente dimenticato. Le rare volte in cui viene raccontato è riportato sotto la generica definizione di conflitto etnico. In altre parole una guerra tra etnie o tribù con caratteri identitari differenti, ciascuna con l’idea di voler affermare il proprio Io sull’Altro. Ma questa definizione è davvero sufficiente?
È di pochi giorni fa la notizia della presa di Masisi, territorio del Nord-Kivu, da parte dei ribelli dell’M23 (Movimento 23 Marzo) e il successivo intervento delle Forze armate della Repubblica Democratica del Congo. Tanto per Kinshasa quanto per l’Onu le azioni dei ribelli sono sotto il comando del Rwanda; dunque (sebbene l’M23 dichiari come principale obiettivo la protezione delle minoranze tusti in Congo) a muovere gli interessi dei ribelli e di Kigali sono le risorse minerarie. In riferimento alla sua geografia per il Congo si è parlato di scandalo geologico: solo nella Cintura del rame ( la Regione che si estende dallo Zambia settentrionale alla Repubblica Democratica del Congo) sono presenti 3,5 milioni di tonnellate di cobalto; una ricchezza così rilevante che da sempre è stata motore di ingerenze straniere. Ad essere sotto accusa non è più solo l’azione rwandese. Nello sfruttamento delle risorse un ruolo determinante è giocato dai legami economici con la Cina. Era stato il vecchio presidente Joseph Kabila a stipulare molti di questi accordi e sebbene sembrasse che l’attuale presidente Félix Tshisekedi volesse discostarsi dal suo predecessore, oltre l’immagine di facciata, la situazione non ha subito grandi cambiamenti.
Tra le voci dal campo quella di K.A, professore a Kinshasa, che racconta lo sfruttamento dei lavoratori congolesi nelle miniere gestite dalle compagnie cinesi. “Né Kabila né Tshisekedi, già al secondo mandato, hanno svolto azioni concrete per una diversa gestione del processo di estrazione mineraria. Pensiamo al numero esorbitante di lavoratori artigianali che sono impiegati in miniere illegali, senza alcuna tutela o prevenzione dei rischi e con stipendi estremamente bassi. Dunque possiamo credere ad un reale impegno del governo di Kinshasa per pacificare l’est del paese? A questa domanda si unisce la consapevolezza che i responsabili della condizione in cui il paese versa sono molteplici attori”.
Il popolo congolese si trova quindi a metà tra l’essere schiacciato da ingerenze straniere e l’essere totalmente ignorato da una comunità internazionale che sembra non accorgersi della guerra in corso. È qui che si può trovare la risposta al perché si usi la categoria di conflitto etnico: tacendo le reali ragioni delle guerre, finalizzate alla gestione delle risorse, si fanno apparire gli scontri come connaturati alla popolazione e alle dinamiche che la caratterizzano e dunque difficilmente risolvibili. È opportuno sottolineare che nelle numerose milizie illegali agiscono soldati appartenenti a tribù diverse, tribù che hanno vissuto a lungo in prossimità senza alcuna tensione, almeno fino a quando non è iniziata una corsa sfrenata al guadagno. L’appartenenza ad un determinato schieramento o le alleanze tra questi sono caratterizzate da una fluidità che demarca la mancanza di una reale influenza etnica. Non fraintendiamo: in Congo la divisione in etnie esiste, ma la modalità con cui i differenti gruppi si relazionano cambia a seconda della parte del paese in cui essi si collocano. A Kinshasa (che pur essendo la capitale non si caratterizza rispetto ad altre zone per fertilità del suolo o presenza di risorse minerarie) i confini tribali sono completamente venuti meno; benché il singolo continui ad identificarsi con la propria tribù, questa non vive in uno spazio delineato separata dalle altre. Si tratta di considerazioni che devono essere ricordate prima di accettare la semplice definizione di conflitto tribale per una guerra che da decenni sta dilaniando il Paese. Non è poi da sottovalutare come, in una condizione di totale disordine, si riesca più facilmente a celare una gestione non trasparente dell’enorme ricchezza mineraria del paese di cui non beneficia in alcun modo la popolazione locale.
Emblematica rimane dunque la riflessione di Frantz Fanon secondo cui “se l’Africa fosse raffigurata come una pistola, il suo grilletto si troverebbe in Congo”. Si dovrebbe aggiungere che quella pistola la caricano coloro che dai proiettili rimarranno illesi, perché ad essere colpito sarà sempre e solo il popolo congolese.
*Laureata all’Università di Pisa con una tesi dal titolo “Conflitti etnici: dal dibattito teorico all’analisi della guerra in Kivu”. Attualmente è studentessa di filosofia all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore.
*In copertina Kinshasa, foto di Filippo Florindo