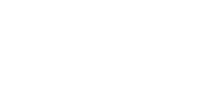di Alice Pistolesi
E’ un Paese, il Bangladesh, sul filo del rasoio. Recentemente è stata condannata la capo dell’opposizione Khaleda Zia, ritenuta coinvolta in un caso di corruzione. La sentenza nei confronti della ex Premier è di cinque anni di carcere, mentre per suo figlio Tarique Rahman, gli anni comminati sono dieci. Come prevedibile questo ha provocato nel febbraio 2018 scontri tra manifestanti e Polizia nelle strade della capitale, Dhaka.
Tutto questo mentre si avvicina la data delle prossime elezioni presidenziali che si dovrebbero tenere nel dicembre 2018. La decisione esclude infatti Zia dalla tornata elettorale spianando la strada all’attuale premier Sheikh Hasina e amplificando la tensione del Paese.
Al contesto politico si aggiunge poi l’emergenza umanitaria dei migliaia di rohingya messi in fuga dall’esercito del Myanmar e che si trovano a vivere in condizioni più che precarie in Bangladesh. I motivi per fuggire dal Paese, dunque, sono più che evidenti e in molti tentano il tutto per tutto per riuscire ad ‘evadere’ dallo stato.
Per affrontare un aspetto di questa fuga merita spazio lo studio dell’antropologo Tommaso Sbriccoli e del giurista Mario Ricca ‘Shylock del Bengala Debiti migratori, vite in ostaggio e diritto d’asilo’ pubblicato sulla rivista CALUMET – intercultural law and humanities review.
Vite appese ad un debito da ripagare. Le storie di molti migranti provenienti dal Bangladesh ci riportano a questa modalità: una libbra di carne, talvolta anche corpi interi, a garanzia del debito.
Un pezzo di carne è quello che “molti aspiranti migranti, a corto di mezzi economici per partire, sono costretti a offrire. Spesso non hanno che il proprio corpo, la propria capacità di lavorare, come garanzia da prestare pur di ottenere i soldi per la partenza”.
Pur di partire i migranti diventano quindi servi volontari. Se non sono in grado di pagare, i creditori, i mahajan, minacciano spesso i familiari dei migranti. Quando possibile, la minaccia si concretizza nella confisca dei loro beni: se il migrante e i suoi familiari possiedono case, terreni, locali per l’esercizio di attività commerciali, tutto viene risucchiato a saldo del ‘debito migratorio’.
Alcune volte, i contratti del prestito, prevedono perfino il “diritto/potere” del creditore di infliggere punizioni fisiche a chi resta a fare da ostaggio.
Due tipologie di contratto di viaggio
Se per ottenere i soldi necessari i migranti si rivolgono a degli usurai, per l’organizzazione del viaggio vero e proprio sono i trafficanti/intermediari, i dalal, ad essere le figure centrali. Le due principali forme attraverso cui il migrante stabilisce la propria relazione con i dalal sono il contratto fisso e quello condiviso.
Nel primo caso, la persona s’impegna a versare una cifra stabilita, che copre tutte le spese e i servizi forniti dall’agenzia privata per la migrazione. A volte, gli accordi prevedono anche che un dalal presente nel paese di migrazione trovi un lavoro al migrante.
Il denaro per pagare le prestazioni viene spesso ottenuto, in parte o integralmente, tramite prestiti a usura, anche se non sono rari i casi di migranti che sono riusciti a far fronte al costo del progetto migratorio grazie a risparmi personali e alla vendita di beni propri o della famiglia.
La seconda forma di contratto, lo shared contract, presuppone lo stabilirsi di un rapporto debitorio con il dalal o il trafficante che prevede che il migrante accetti di lavorare per il trafficante nel paese di destinazione fino a che tutti i costi di migrazione siano stati ripagati.
“Naturalmente, al costo iniziale vengono applicati interessi usurai, – scrivono Sbriccoli e Ricca – e le condizioni di vita e di lavoro del migrante sono scandite da pratiche continue di controllo che rendono la sua condizione simile a quella di uno schiavo. Il ritiro del passaporto, orari di lavoro estenuanti, l’impossibilità di allontanarsi dal posto di lavoro (dove spesso i migranti vengono anche fatti dormire), e l’incertezza circa la possibilità di saldare quanto dovuto (spesso anche per la totale arbitrarietà dell’interesse applicato al debito), sono caratteristiche di molti casi in cui lo shared contract è il tipo di relazione istituita con il trafficante”.
Lo scenario
Il Bangladesh è uno degli stati più poveri del mondo. Metà della sua popolazione vive con meno di 1,2 dollari al giorno e quasi un terzo è al di sotto della soglia di povertà. Nel 2012, circa il 40% della popolazione era sotto-occupata.
La mancanza del lavoro, la povertà e il mancato rispetto dei diritti umani spingono molti dei suoi abitanti a lasciare il Paese.
Il Paese inoltre ha pochi terreni coltivabili ed è soggetta a continue inondazioni che si alternano a periodi di siccità estrema.
In queste condizioni, alcune fasce della popolazione, ovvero quelle più povere e marginali, si trovano in una situazione di tale precarietà che ogni evento fuori dalla norma (un raccolto perso, una disputa legale, un’eredità contesa) può gettarli da un momento all’altro in una situazione di totale esclusione sociale e crisi economica. In questi casi, le reti locali di sfruttamento, dipendenza e sopruso stringono la loro presa e spesso non lasciano loro altra possibilità se non quella di partire.
Debito, patto commissorio e protezione
La fuga, quindi, rappresenta in questi casi non solo come unica opzione, ma anche come il frutto di pressioni da parte dei potenti locali (usurai e trafficanti) che su tali viaggi speculano abbondantemente. Il debito contratto, oltre a prevedere interessi altissimi, spesso attiva infatti anche un’altra forma di estrazione sui malcapitati: la garanzia reale dei propri beni immobili (case, negozi, terreni) dati in pegno in cambio del prestito.
In caso di mancato pagamento di interessi e/o capitale nei tempi previsti, l’usuraio incamera anche questi beni, lasciando le persone senza nulla se non il loro corpo (che spesso diviene oggetto di ulteriore estrazione attraverso il lavoro forzato, cui i familiari dei debitori inadempienti possono essere costretti). Questotipo di pratica, conosciuta nel nostro ordinamento come Patto Commissorio, viene vietata dagli articoli 2744 e 1963 del Codice Civile. Nonostante lo scenario di arrivo, il pericolo che le persone che hanno contratto il debito affronterebbero nel tornare a casa, e l’esplicita presenza nei nostri Codici del divieto di tali pratiche, la giurisprudenza ha finora ignorato tale problematica, non riconoscendo a queste persone alcuna forma di protezione.
Scrivono gli autori “in Bangladesh non c’è guerra, lì non sei perseguitato per ragioni razziali, religiose ecc.: dunque torni. Richiesta d’asilo rigettata”.
Eppure, se i migranti tornassero i creditori potrebbero pretendere la loro libbra di carne, purtroppo, non solo in senso figurato.
“Sta tutto qui – continuano – lo scarto tra la loro situazione e quella ordinariamente, sebbene impropriamente, etichettata come di “migrante economico”, sinonimo di “migrante irregolare” e non legittimato ad ottenere asilo o altre forme di protezione”. “Del resto, non è facile uscire da una visione per la quale, quando si sia in presenza di denaro (contratti, prestiti, ecc.), le ragioni alla base delle azioni umane non possono che essere lette in termini prettamente economicisti. Nel caso descritto, come in molti altri, il denaro appare piuttosto essere lo strumento attraverso cui la dipendenza, lo sfruttamento, persino la persecuzione, fanno presa sulle vite e i corpi di chi è costretto a fuggire dalla propria terra”.